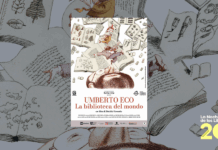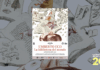Signoria di Camerino, 1433 – Gli zoccoli dei cavalli rompevano il silenzio di un’alba umida e fredda, tenendo lo stesso ritmo frenetico del suo cuore. Il sangue le pulsava nelle vene per la paura e per l’adrenalina: i suoi sensi erano allerta, nonostante le sembrasse di sentir ronzare una nube di vespe. Il capitano Venanzio le strattonò con delicatezza un gomito: "Signora, per di qua!". Dovevano lasciare la strada maestra e imboccare un sentiero secondario per salire fino ai monti, dove avevano una speranza di salvarsi. Elisabetta strinse le briglie del destriero, poi lanciò un’occhiata ai bambini per accertarsi che fossero tenuti stretti, specialmente il suo unico figlio maschio Rodolfo, venuto al mondo da appena qualche mese, ma già in pericolo di vita. Alle sue spalle udì delle grida maschili portate dal vento. Un giorno, forse, sarebbe tornata; ora era il momento di fuggire lontano.
Quando Elisabetta giunse stremata alla fortezza di Visso insieme ai suoi uomini più fedeli, il sole era ormai alto in cielo e i suoi raggi caldi facevano brillare le cime innevate dei Monti Sibillini. Avevano cavalcato senza sosta lungo la strada che da Muccia conduceva per Pievetorina, Macereto e Villa Sant’Antonio: paesaggi meravigliosi che in un altro momento si sarebbe fermata ad ammirare, colma di gratitudine per quella terra che aveva ricevuto in dono sposando una decina d’anni prima Piergentile da Varano, Signore di Camerino. Ora, invece, gli unici sentimenti che la invadevano e la straziavano erano il terrore e la rabbia: pochi giorni addietro, infatti, i due fratelli maggiori del marito, nati dal primo matrimonio del suocero Rodolfo III, si erano uniti in una congiura capeggiata dal sanguinario vescovo e condottiero militare Giovanni Maria Vitelleschi contro Piergentile e Giovanni, eredi di secondo letto.
Bartolomea, la consorte di Giovanni, era caduta in un baratro di dolore quando la cognata Tora le aveva riferito che suo marito era stato ucciso senza pietà a palazzo. A nulla erano serviti i tentativi di infonderle coraggio e trasmetterle fiducia: la donna aveva preferito chiudersi in convento piuttosto di tentare la fuga, affidando a Elisabetta la responsabilità di proteggere il figlio Giulio Cesare. Grazie al cielo il comandante delle truppe camerti Venanzio non aveva perso tempo, conducendo la famiglia in salvo prima ancora di conoscere le sorti di Piergentile. E sempre grazie al cielo quel giorno, alle prime luci dell’alba, la città di Visso aveva aperto loro le porte, accogliendoli tra mura sicure. Quanto meno non erano soli nell’affrontare quell’impresa disperata.
Elisabetta Malatesta da Varano era nata a Pesaro nel 1407 da due delle più importanti famiglie nobiliari dell’Italia centrale: i Malatesta e i Montefeltro. La madre Battista, celebre erudita e scrittrice del Rinascimento italiano, le aveva impartito un’educazione impeccabile, instillando in lei l’amore per le arti e la cultura. Chiusa nell’alta torre di Visso, che la proteggeva tanto quanto la imprigionava in attesa di notizie dalla sua Camerino, Elisabetta ripensava con le lacrime agli occhi agli anni felici trascorsi nella Signoria insieme al marito Piergentile, un uomo che teneva fede con i fatti al proprio nome. Gentile con lei lo era stato davvero e, sebbene il loro fosse un matrimonio combinato, l’amore era riuscito a sbocciare tra le fitte trame tessute dalla politica. Quei ricordi nostalgici durarono un mese, fino al giorno in cui Venanzio entrò nella torre portando con sé l’odore della pioggia e delle brutte notizie: Piergentile era stato appena decapitato fuori dalle mura di Recanati.
Morivano così un uomo, un amore, un futuro di pace e libertà. La scomparsa del marito fu solo la prima grande sofferenza che Elisabetta conobbe nel corso della sua lunga esistenza: a essa fecero seguito la morte dell’amata figlia Costanza a soli 21 anni, deceduta di parto poco dopo aver sposato Francesco Sforza in un’unione strategica e al contempo desiderata da entrambi, proprio come la sua; poi fu la volta della madre Battista, della seconda figlia Primavera e infine dell’erede Rodolfo, che il 14 dicembre del 1443 aveva finalmente ottenuto la Signoria di Camerino insieme al cugino Giulio Cesare. Fu quest’ultima perdita a segnarla del tutto nel corpo e nell’anima, poiché se così a lungo era riuscita a mantenersi in vita, se aveva affrontato esili e fughe rocambolesche, se aveva tramato e complottato fino a sporcarsi le mani di sangue, era stato sempre e solo per restituire a suo figlio il titolo di Signore di Camerino che gli spettava per nascita.
Per vent’anni lo aveva visto governare una città felice e appagata, grazie anche alla guida di validi tutori e primi ministri. Senza mai interferire, ma orgogliosa come solo una madre può essere, lo aveva osservato crescere dapprima dalle sue stanze nobili a Palazzo Varano, poi – dopo la tragedia di Costanza – dalle umili celle dei conventi di Foligno e Perugia, dove si era rifugiata per fuggire dalla sofferenza, dal mondo e dai propri peccati. Quando infine anche lui venne a mancare, Elisabetta reagì con grande dignità alla perdita; tuttavia, si chiuse sempre più nella propria intimità, isolandosi dalle influenze esterne e mantenendo vicine solo poche persone fidate, tra cui la nipote Battista Sforza.
Elisabetta da Varano morì all’età di settant’anni nel Convento di Santa Chiara a Urbino, dove l’aveva voluta in veste di badessa Federico da Montefeltro in persona. Scampò alla congiura del 1433 portando in salvo l’intera famiglia, e di nuovo riuscì a condurre i suoi figli lontano dall’eco delle armi nel 1434, quando una ribellione trucidò quasi l’intera stirpe dei da Varano, ponendo fine al loro governo e istituendo la repubblica borghese. Durante i nove anni che trascorse in esilio a Pesaro presso la corte del padre Galeazzo Malatesta, risorse dalle ceneri come una fenice, trasformando il proprio cuore in ghiaccio e giurando di riconsegnare, un giorno, la Signoria di Camerino a suo figlio Rodolfo e al nipote Giulio Cesare.
Quel giorno arrivò davvero nel 1443 grazie alla sua tenacia e all’abilità di stringere alleanze, combinare matrimoni, riunire eserciti, affascinare condottieri, re e duchi, giocando sempre con astuzia la propria partita nella scacchiera di un’Italia centrale sconquassata dalle lotte tra Sforzeschi e Bracceschi. Sebbene Rodolfo, insieme al cugino Giulio Cesare, riottenne Camerino acclamato dalla folla e sostenuto dal Papa, dopo soli cinque anni Elisabetta scelse la via della spiritualità, sentendo il bisogno di concludere la sua vita vicino a Dio. Quando morì, la Signoria splendeva capeggiata da Giulio Cesare da Varano, il popolo la ricordava con tenerezza, Federico da Montefeltro le aveva persino affidato un monastero. La sua famiglia, tuttavia, l’aspettava altrove da molto tempo.
A lungo dimenticata a causa della Damnatio memoriae, di cui fu vittima poiché durante l’attacco per instaurare la repubblica furono dati alle fiamme gli archivi di casa Varano e di Camerino, la figura di Elisabetta è stata recentemente riportata alla luce da due romanzi storici della scrittrice Clara Schiavoni: "Sono tornata" e "Saprò ricominciare", editi da Affinità Elettive. Come accadde ad altre donne sue contemporanee, la gentilezza e la cultura non furono d’intralcio alla capacità di prendere in mano il proprio destino quando gli eventi girarono a loro sfavore. Oggi la ricordiamo come una delle donne più coraggiose, indipendenti e moderne del Rinascimento italiano.
Chiara Giacobelli