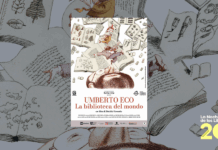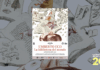di Pietro Salvatori
C'è Godot che seduto sul ciglio della strada sta aspettando Giuseppe Conte. Gli passano davanti dossier, nomine, fondi, decreti decisivi, e lui sta lì, aspetta e li lascia passare, scrutando la strada per Volturara Appula che rimane desolatamente vuota.
Il Movimento 5 stelle cinque mesi fa era nella stanza dei bottoni, non si muoveva foglio che un ministro o un sottosegretario non vagliasse. Sulla capacità di comprenderli e governarli si può ampiamente discutere, ma il concetto era quello, le leve in mano a un premier espressione del principale partito in Parlamento, un Recovery plan da intestarsi e sul quale poter fare il bello e il cattivo tempo, sempre "nell'interesse dei cittadini" ovviamente.
Oggi nella stanza dei bottoni è rimasto uno strapuntino, il polso dell'agenda è stato totalmente perduto (do you remember Autostrade? do you remember Ilva?), ci si trincera nell'afonia, se va bene, nel caos se è la norma. Prendiamo il tema dei licenziamenti. Da giorni il governo si accapiglia intorno alle norme proposte da Andrea Orlando, prorogare o no i licenziamenti fino a fine agosto, Lega Pd e Forza Italia a darsele di santa ragione, Palazzo Chigi a mediare. Ieri mattina se chiedevi la linea ad alcuni dei massimi dirigenti pentastellati la risposta standard era "Ah boh, senti Tizio", il corollario "Non ne ho idea, se ne occupa Caio".
Non c'è un capo a dare la linea, non c'è linea. Come ama ripetere uno degli strateghi di questi ultimi dieci anni "siamo uniti dai cinque temi delle cinque stelle, fuori da quelli non abbiamo nulla da dirci". E quindi i licenziamenti. Verso il tardo pomeriggio esce una nota congiunta dei senatori della commissione Lavoro (le "note congiunte" dei 5 stelle sono un genere letterario a parte, un po' uno vale uno, un po' vai avanti tu che poi arrivo). I prodi sentori 5 stelle piantano una bandierina dicendo che il blocco deve essere prorogato fino alla fine dell'anno, come se il dibattito delle ore precedenti non fosse esistito, come se l'ex ministra Nunzia Catalfo non fosse stata impallinata quotidianamente dai suoi compagni di partito perché accusata di essere troppo appiattita dai sindacati.
E dunque la truppa parlamentare in assenza di qualcosa di meglio esprimeva una posizione destinata a rimanere irrilevante nel dibattito politico, con Orlando a difendere la proroga fino a fine agosto "perché sono consapevole che con questa maggioranza oltre non si può" e con Mario Draghi che intanto aveva già imposto una mediazione ancora più al ribasso: via lo stop dal primo luglio, via le addizionali per chi continua con la cassa integrazione.
Dopo ventiquattr'ore di attesa il capo delegazione di governo Stefano Patuanelli si accorge che forse così non si tocca palla, e decide di uscire a difesa di Orlando e del suo compromesso. Non si detterà l'agenda, almeno ci si infila nel dibattito.
Ci si deve accontentare di quel poco che resta di un partito che da mesi ha deciso di dare notizia solo per quel che succede nel retrobottega, con un capo che non è ancora un capo, un reggente che non è un reggente e che non sa chi siano i propri attivisti, perché l'elenco è chiuso in una cassaforte che nessuno di loro può aprire.
Un poco che può essere quantificato. Ieri in una riunione di una mezz'oretta o poco più Mario Draghi ha deciso che la gestione del Pnrr sarà sua e del ministro dell'Economia Daniele Franco, uno che quando era Ragioniere generale dello stato ha subito una strenua guerriglia a bassa intensità da parte dei 5 stelle, così come Roberto Garofoli, oggi plenipotenziario di Palazzo Chigi.
Gli altri ministri? Coinvolti a geometria variabile, e dunque di volta in volta quando si tratterà di temi su cui hanno competenza. Fino a cinque mesi fa i duecento e passa miliardi del Recovery passavano dalle mani di Conte, Casalino, Di Maio, Bonafede ecc. ecc., oggi se va bene avranno voce in capitolo sui sei che spettano all'agricoltura in mano a Patuanelli.
L'ex Guardasigilli si tiene fuori dalla mischia, in attesa di tempi migliori. È nel suo carattere, c'è anche un calcolo politico. La riforma della giustizia che sta mettendo a punto Marta Cartabia si concorda con Palazzo Chigi, i partiti convocati a (pochi) tavoli di sintesi che diventano poco più di un contentino. Le sue riforme rischiano ben presto di diventare carta straccia, la prescrizione è sulla via di essere reintrodotta e tanti saluti alla Spazzacorrotti.
Qualche anno fa i 5 stelle avrebbero occupato il tetto della Camera, i banchi del governo, avrebbero urlato alla dittatura mentre oggi si sente solo qualche vagito, che fatica a fare capolino dalla gran cagnara che s'alza dalle forze di maggioranza.
Critichi Matteo Salvini per la strumentalità delle sue posizioni, critichi Enrico Letta per l'estemporaneità delle sue proposte. Nei 5 stelle non c'è nessuno da criticare, a meno che non si voglia attaccare Crimi per l'inefficacia (eufemismo) della sua gestione transitoria. Criticavano Stefano Buffagni per una gestione delle nomine ritenuta spregiudicata da alcuni. Bei tempi. Oggi quelle nomine sfrecciano nel cielo, comete inafferrabili, senza che nessuno abbia voce in capitolo, senza nessuno che orchestri una strategia, individui priorità, faccia quel lavoro sartoriale da retroscena per arrivare dove si vuole arrivare (ma dove si vuole arrivare?).
E così è in procinto di saltare la testa di Fabrizio Palermo, piazzato in Cassa depositi e prestiti quando doveva essere trasformata in un grande prestatore pubblico di ultima istanza, idea visionaria di Casaleggio che su Casaleggio stesso ha gettato sospetti e veleni, "gli interessa solo per i suoi affari privati". Oggi Casaleggio non c'è più, domani non ci sarà più Palermo, Buffagni è da un po' che si è ritirato sull'argine del fiume, sul quale a breve passeranno amministratori delegati e consiglieri d'amministrazione che faranno ciao con la manina, mentre fino a qualche mese fa avrebbero ossequiato chi aveva in mano le sorti del loro destino.
Non si espone Luigi DI Maio, e come biasimarlo, che ritorna carsico nei discorsi stile "ah, quando c'era lui..", che dalla Farnesina si sta pezzetto pezzetto costruendo un futuro per il dopo, perché un dopo dovrà pur esserci. "Il miglior modo per affrontare le semplificazioni e spendere i soldi del Next generation Eu è parlare con i sindaci", ha detto il ministro degli Esteri. Proprio quei sindaci che vogliono allentare controlli e accorciare le gare per avere più capacità di indirizzo e di spesa, molti dei quali spingono per la logica del "massimo ribasso", sul quale un altro decreto Semplificazioni, quello di Conte, si incagliò per settimane.
"No a al massimo ribasso sugli appalti", hanno tuonato invece i deputati nelle commissioni Ambiente, Attività produttive e Trasporti (sempre per il filone letterario di cui sopra), una babele da cui non se ne esce. Fino a qualche mese fa c'era Beppe Grillo, che con tutti i suoi limiti se diceva A era A, ci si agitava, si smaniava, ci si contorceva ma poi si andava tutti lì, oggi in altre faccende molto personali affaccendato. L'ultima intemerata, il sì a Draghi, ha provocato la scissione più dolorosa. E quindi non ci sono più i Nicola Morra, le Barbara Lezzi, gli Alessandro Di Battista, spesso mal tollerati, spesso divisivi, ma altrettanto spesso capaci di generare attenzione, fosse anche solo per una mezza giornata, intorno a un Movimento ormai immobile nelle sue contraddizioni.
Arriveranno un nuovo statuto e una nuova carta dei valori, ha promesso Conte. A brevissimo, anzi no a inizio maggio, anzi no entro giugno, e le cinque stelle che erano gli unici cinque punti che mettevano tutti d'accordo forse spariranno o forse diventeranno sette, non si sa, e se ne parla nelle chat dei parlamentari, e si risponde sempre più stancamente alle domande dei giornalisti. Nel Movimento prima si sono circondati, poi si sono arresi.