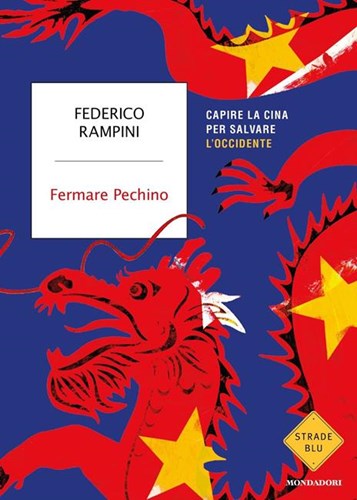L’etichetta “made in China” non era stata ancora inventata, eppure la civiltà cinese esisteva già, ed era fiorente ed evoluta. Nemmeno il nome Cina non esisteva: sarebbe nato solo con la Qin che, appunto, si pronuncia cin. Si tratta di una dinastia che, come ricorda Federico Rampini nel suo ultimo saggio (Fermare Pechino: Capire la Cina per salvare l’Occidente, Mondadori editore), unifica sotto un’unica amministrazione gran parte del territorio cinese a partire dal 221 avanti Cristo. La terra della seta, che in seguito arriverà in Europa grazie a due monaci, e contrabbandieri, nestoriani, sarebbe poi divenuta, durante il medioevo e per merito di Marco Polo, il famoso Catai. Non sono trascurabili i segni della presenza di tale civiltà all’arte occidentale: basti pensare all’Adorazione dei Magi dipinta da Giotto nella basilica inferiore di Assisi, in cui sono riconoscibili due personaggi cinesi, o a un affresco del Pisanello, San Giorgio e la principessa, che si trova nella chiesa di Sant’Anastasia a Verona, e in cui sono ben visibili due cavalieri dai tratti somatici asiatici, o ad alcune opere di Ambrogio Lorenzetti.
Ma soprattutto Rampini ci ricorda che Confucio è più antico di Machiavelli e che ha insegnato ai cinesi “il rispetto per l’istruzione, il senso delle gerarchie e delle regole, la venerazione per i padri, la capacità di anteporre la comunità all’individuo”, tanto che lo ammirarono anche Voltaire e Montesquieu. Sulla civiltà cinese ebbe però una grande influenza anche il buddismo, e con esso una sua certa idea del diavolo di cui ci ha trasmesso dei simboli: nel tardo medioevo, per esempio, il demonio veniva spesso raffigurato come un pipistrello, che assomiglia molto al dragone della tradizione cinese, tanto da poter suggerire l’ipotesi semiseria che il covid sia partito non per caso proprio dalla Cina, e dai pipistrelli.
Dal Medioevo molta acqua è passata sotto i ponti. Com’è noto, dopo l’era comunista e la morte di Mao Tse-tung l’economia cinese è cresciuta in modo impressionante e oggi non ci sono pareri concordanti su come il regime cinese debba essere classificato sotto il profilo politico. Secondo Rampini il modello cui si rifà la Cina attuale “è un misto di comunismo (nel senso del primato del Partito comunista), di paternalismo confuciano (il rispetto delle gerarchie, dell’autorità, l’imperatore come un padre di famiglia), di meritocrazia e di tecnocrazia (fiducia negli esperti al governo)”; ma un comunismo che contempla la proprietà privata dei mezzi di produzione e produce un così elevato numero di miliardari potrebbe solo far rivoltare nella tomba Marx, Lenin e Mao Tse-tung. È vero che esiste una forte presenza dello Stato nelle imprese cinesi, ma quest’economia mista la fa assomigliare di più a un regime di tipo fascista che non a uno comunista. E tuttavia la Cina continua a definirsi tale, perché è coerente con la storia della classe dirigente al potere e perché l’altra categoria politica sarebbe per ovvi motivi fuori luogo e assai inopportuna sotto ogni profilo.
D’altra parte, il presidente cinese non perde occasione per ribadire che il loro sistema economico e politico è più efficiente di quelli in vigore nelle democrazie occidentali: mentre noi cerchiamo di selezionare i governanti migliori e creiamo instabilità andando in continuazione alle urne, i loro dirigenti sono selezionati attraverso i risultati che producono. Ora, sebbene si possano avanzare legittimi dubbi sul fatto che tale sistema politico sia realmente più performante del nostro, in un’epoca in cui l’occidente manifesta sempre più chiaramente segni d’indifferenza per la liberaldemocrazia il presidente Xi ha buon gioco nel sostenere che il nostro modello politico è incapace di rispondere ai bisogni dei cittadini. E non è il solo a pensarla così, perché è opinione abbastanza diffusa, sia in Cina sia altrove, che i diritti individuali non interessino molto i cinesi e che una liberalizzazione del Paese potrebbe avere effetti poco controllabili, se non addirittura catastrofici.
In questo scenario, cosa fanno gli Stati uniti e l’Europa? Joe Biden ha lanciato uno slogan efficace per contrassegnare la sua presidenza: “L’America è tornata”; ma “il “ritorno” in questione si riferisce al rilancio di una tradizione diplomatica imperniata sulle alleanze tra nazioni dai valori affini. Biden l’ha rinnovata con due aggiornamenti. Anzitutto ha reso esplicito lo scopo di queste alleanze: rafforzare le coalizioni di liberaldemocrazie in una fase di avanzata degli autoritarismi, in particolare quello cinese; mentre l’altro filo conduttore della visita è stata l’idea che le democrazie devono dimostrare in modo concreto l’efficacia dei propri sistemi politici, dato che non ci si può accontentare di proclamare in linea di principio la bontà dei nostri valori: bisogna produrre risultati che creino consensi tra i cittadini, così come a modo suo il regime comunista cinese ha realizzato delle performance di sviluppo e modernizzazione innegabili”.
Almeno per il momento simili risultati sono però lontani da venire, come confermano i recenti sondaggi che evidenziano un deciso calo della popolarità di Biden nei consensi. In questo frangente, già molto precario, i progressisti americani, o almeno quelli che si considerano tali, hanno scritto nel frattempo nuove regole Politically correct che le multinazionali ostentano di voler adottare per salvare la propria anima e darsi un’immagine al passo coi tempi: sostenibilità ambientale, femminismo, antirazzismo “sono all’ordine del giorno nei consigli d’amministrazione di colossi che valgono centinaia o migliaia di miliardi in Borsa”. Tuttavia, quando questi miliardari etici si sono imbattuti nel sistema politico illiberale cinese e hanno cercato di opporsi a quel regime boicottandone i prodotti per ragioni umanitarie si soni visti costretti a fare una rapida retromarcia.
Del resto, siamo proprio sicuri di essere diventati tutti ambientalisti? Da Xi Jinping a Joe Biden, da Jack Ma a Jeff Bezos, “i potenti della terra hanno in comune un nuovo Vangelo: la sostenibilità. Leader politici che continuano ad autorizzare la costruzione di nuove centrali a carbone o chief executive di multinazionali dall’impatto ambientale distruttivo abbracciano la retorica dell’emergenza climatica. Quanto c’è di sincero, quanto invece fa parte di un travestimento ideologico? La pratica del Greenwashing pervade la nostra vita quotidiana, ci insegue come consumatori o come cittadini. Greenwashing letteralmente significa dare una lavata di colore verde”.
A giudicare dai comportamenti e dalle strategie concrete c’è molto fumo verde e poco arrosto ambientale. Molti prodotti vengono infatti reclamizzati “su uno scenario naturale come se fossero “amici dell’ambiente” mentre non lo sono affatto (vedi gli spot televisivi che mostrano Suv in mezzo alle foreste)” e “Starbucks ha pubblicizzato contenitori di caffè biodegradabili, che in realtà contengono più plastica delle versioni precedenti. Jeff Bezos, fondatore di Amazon, si è scoperto ambientalista e ha creato un fondo di 10 miliardi (pochi spiccioli in proporzione alla sua ricchezza) per azioni filantropiche nella lotta all’emergenza climatica. Però il modello Amazon si fonda sulla proliferazione di rifiuti – imballaggi di cartone e carta – nonché sull’uso di flotte di aerei, camion e navi che tuttora funzionano con carburanti fossili”.
In questo contesto di propaganda ambientalista piuttosto strumentale e ipocrita si continuano a importare dalla Cina in tutto il resto del mondo grandi quantità di cotone che è in buona parte lavorato da condannati ai lavori forzati, da “uiguri spediti nei “campi di rieducazione” per estirpare la religione musulmana dalle loro teste. Sicché esiste il rischio concreto che un consumatore di una grande marca occidentale stia – indirettamente – collaborando con la persecuzione di quel popolo a opera del regime di Pechino”. Anche grazie allo sfruttamento di questa particolare tipologia di risorse umane la Cina ha potuto accumulare negli ultimi anni così tante ricchezze da superare gli investimenti in ricerca degli Stati Uniti, e attualmente “Pechino è vicina a conquistare anche la leadership mondiale nell’intelligenza artificiale, un insieme di tecnologie con immense potenzialità sia per lo sviluppo economico sia per gli usi militari”.
Non si tratta di certo di una prospettiva rassicurante, e se Thomas Robert Malthus aveva già previsto, nel XIX secolo, “un’umanità condannata dalla sovrappopolazione e dalle carestie”, una simile catastrofe, già ampiamente in corso da vari lustri, da qualche anno non è di sicuro la più temuta, ammesso che lo sia mai stata. Secondo Rampini, infatti, la Cina oggi fa ancora più paura: per ragioni ambientali, geopolitiche e militari. Ciononostante, non si possono affrontare razionalmente tali fondati timori se non si considerano le difficoltà obiettive che possono esserci nel governare un Paese di 1,4 miliardi di persone: la Cina ha infatti già abbastanza da fare per salvare i suoi connazionali per potersi occupare con qualche effettivo senso della responsabilità del resto del mondo.
Pur essendo vero che l’economia cinese ha un impatto sull’ambiente globale superiore alla media e pur continuando la Cina a costruire nuove centrali a carbone, non si possono tuttavia ignorare le obiettive esigenze energetiche di un Paese così popoloso, che negli ultimi trent’anni ha visto aumentare tanto rapidamente il potere d’acquisto dei suoi cittadini e le sue capacità produttive. Un protezionismo ben temperato verso suoi prodotti potrebbe forse costituire la strategia migliore per arginare gli effetti negativi della sua economia su quella di tutto l’occidente e sugli equilibri geopolitici internazionali, ma anche per poter adottare una politica simile sarebbe necessaria una unità d’intenti e di analisi che oggi è ben lontana dall’essere all’orizzonte. Anche se Biden pare aver sottratto a Donald Trump la bandiera del protezionismo, la crescente indifferenza per i valori della liberaldemocrazia che si sta diffondendo in tutto l’occidente rende problematica l’adozione di qualsiasi strategia che non sia improntata al conseguimento di un vantaggio immediato e tangibile, con tutta la scarsa lungimiranza che una simile prospettiva comporta e tutte le insidie che ne conseguono.
A tutto questo bisogna poi aggiungere l’alleanza, strategica di fatto, con la Russia di Vladimir Putin, la quale, mentre impegna tutto l’occidente sul fronte europeo trova nella Cina un alleato prezioso nel pacifico, dove la difesa di Taiwan costringe gli Stati Uniti a impegnarsi in una doppia tutela di principi e di trattati internazionali che non possono essere lasciati a disposizione di Stati illiberali e autocratici con la disinvoltura con cui il polpo lascia i suoi tentacoli ai predatori di turno, pena il loro rafforzamento geopolitico e una guerra che, in un futuro non remoto, potrebbe rivelarsi, per un’alleanza di potenze declinanti, ancor più dolorosa e ardua da sostenere.L’etichetta “made in China” non era stata ancora inventata, eppure la civiltà cinese esisteva già, ed era fiorente ed evoluta. Nemmeno il nome Cina non esisteva: sarebbe nato solo con la Qin che, appunto, si pronuncia cin. Si tratta di una dinastia che, come ricorda Federico Rampini nel suo ultimo saggio (Fermare Pechino: Capire la Cina per salvare l’Occidente, Mondadori editore), unifica sotto un’unica amministrazione gran parte del territorio cinese a partire dal 221 avanti Cristo. La terra della seta, che in seguito arriverà in Europa grazie a due monaci, e contrabbandieri, nestoriani, sarebbe poi divenuta, durante il medioevo e per merito di Marco Polo, il famoso Catai. Non sono trascurabili i segni della presenza di tale civiltà all’arte occidentale: basti pensare all’Adorazione dei Magi dipinta da Giotto nella basilica inferiore di Assisi, in cui sono riconoscibili due personaggi cinesi, o a un affresco del Pisanello, San Giorgio e la principessa, che si trova nella chiesa di Sant’Anastasia a Verona, e in cui sono ben visibili due cavalieri dai tratti somatici asiatici, o ad alcune opere di Ambrogio Lorenzetti.
Ma soprattutto Rampini ci ricorda che Confucio è più antico di Machiavelli e che ha insegnato ai cinesi “il rispetto per l’istruzione, il senso delle gerarchie e delle regole, la venerazione per i padri, la capacità di anteporre la comunità all’individuo”, tanto che lo ammirarono anche Voltaire e Montesquieu. Sulla civiltà cinese ebbe però una grande influenza anche il buddismo, e con esso una sua certa idea del diavolo di cui ci ha trasmesso dei simboli: nel tardo medioevo, per esempio, il demonio veniva spesso raffigurato come un pipistrello, che assomiglia molto al dragone della tradizione cinese, tanto da poter suggerire l’ipotesi semiseria che il covid sia partito non per caso proprio dalla Cina, e dai pipistrelli.
Dal Medioevo molta acqua è passata sotto i ponti. Com’è noto, dopo l’era comunista e la morte di Mao Tse-tung l’economia cinese è cresciuta in modo impressionante e oggi non ci sono pareri concordanti su come il regime cinese debba essere classificato sotto il profilo politico. Secondo Rampini il modello cui si rifà la Cina attuale “è un misto di comunismo (nel senso del primato del Partito comunista), di paternalismo confuciano (il rispetto delle gerarchie, dell’autorità, l’imperatore come un padre di famiglia), di meritocrazia e di tecnocrazia (fiducia negli esperti al governo)”; ma un comunismo che contempla la proprietà privata dei mezzi di produzione e produce un così elevato numero di miliardari potrebbe solo far rivoltare nella tomba Marx, Lenin e Mao Tse-tung. È vero che esiste una forte presenza dello Stato nelle imprese cinesi, ma quest’economia mista la fa assomigliare di più a un regime di tipo fascista che non a uno comunista. E tuttavia la Cina continua a definirsi tale, perché è coerente con la storia della classe dirigente al potere e perché l’altra categoria politica sarebbe per ovvi motivi fuori luogo e assai inopportuna sotto ogni profilo.
D’altra parte, il presidente cinese non perde occasione per ribadire che il loro sistema economico e politico è più efficiente di quelli in vigore nelle democrazie occidentali: mentre noi cerchiamo di selezionare i governanti migliori e creiamo instabilità andando in continuazione alle urne, i loro dirigenti sono selezionati attraverso i risultati che producono. Ora, sebbene si possano avanzare legittimi dubbi sul fatto che tale sistema politico sia realmente più performante del nostro, in un’epoca in cui l’occidente manifesta sempre più chiaramente segni d’indifferenza per la liberaldemocrazia il presidente Xi ha buon gioco nel sostenere che il nostro modello politico è incapace di rispondere ai bisogni dei cittadini. E non è il solo a pensarla così, perché è opinione abbastanza diffusa, sia in Cina sia altrove, che i diritti individuali non interessino molto i cinesi e che una liberalizzazione del Paese potrebbe avere effetti poco controllabili, se non addirittura catastrofici.
In questo scenario, cosa fanno gli Stati uniti e l’Europa? Joe Biden ha lanciato uno slogan efficace per contrassegnare la sua presidenza: “L’America è tornata”; ma “il “ritorno” in questione si riferisce al rilancio di una tradizione diplomatica imperniata sulle alleanze tra nazioni dai valori affini. Biden l’ha rinnovata con due aggiornamenti. Anzitutto ha reso esplicito lo scopo di queste alleanze: rafforzare le coalizioni di liberaldemocrazie in una fase di avanzata degli autoritarismi, in particolare quello cinese; mentre l’altro filo conduttore della visita è stata l’idea che le democrazie devono dimostrare in modo concreto l’efficacia dei propri sistemi politici, dato che non ci si può accontentare di proclamare in linea di principio la bontà dei nostri valori: bisogna produrre risultati che creino consensi tra i cittadini, così come a modo suo il regime comunista cinese ha realizzato delle performance di sviluppo e modernizzazione innegabili”.
Almeno per il momento simili risultati sono però lontani da venire, come confermano i recenti sondaggi che evidenziano un deciso calo della popolarità di Biden nei consensi. In questo frangente, già molto precario, i progressisti americani, o almeno quelli che si considerano tali, hanno scritto nel frattempo nuove regole Politically correct che le multinazionali ostentano di voler adottare per salvare la propria anima e darsi un’immagine al passo coi tempi: sostenibilità ambientale, femminismo, antirazzismo “sono all’ordine del giorno nei consigli d’amministrazione di colossi che valgono centinaia o migliaia di miliardi in Borsa”. Tuttavia, quando questi miliardari etici si sono imbattuti nel sistema politico illiberale cinese e hanno cercato di opporsi a quel regime boicottandone i prodotti per ragioni umanitarie si soni visti costretti a fare una rapida retromarcia.
Del resto, siamo proprio sicuri di essere diventati tutti ambientalisti? Da Xi Jinping a Joe Biden, da Jack Ma a Jeff Bezos, “i potenti della terra hanno in comune un nuovo Vangelo: la sostenibilità. Leader politici che continuano ad autorizzare la costruzione di nuove centrali a carbone o chief executive di multinazionali dall’impatto ambientale distruttivo abbracciano la retorica dell’emergenza climatica. Quanto c’è di sincero, quanto invece fa parte di un travestimento ideologico? La pratica del Greenwashing pervade la nostra vita quotidiana, ci insegue come consumatori o come cittadini. Greenwashing letteralmente significa dare una lavata di colore verde”.
A giudicare dai comportamenti e dalle strategie concrete c’è molto fumo verde e poco arrosto ambientale. Molti prodotti vengono infatti reclamizzati “su uno scenario naturale come se fossero “amici dell’ambiente” mentre non lo sono affatto (vedi gli spot televisivi che mostrano Suv in mezzo alle foreste)” e “Starbucks ha pubblicizzato contenitori di caffè biodegradabili, che in realtà contengono più plastica delle versioni precedenti. Jeff Bezos, fondatore di Amazon, si è scoperto ambientalista e ha creato un fondo di 10 miliardi (pochi spiccioli in proporzione alla sua ricchezza) per azioni filantropiche nella lotta all’emergenza climatica. Però il modello Amazon si fonda sulla proliferazione di rifiuti – imballaggi di cartone e carta – nonché sull’uso di flotte di aerei, camion e navi che tuttora funzionano con carburanti fossili”.
In questo contesto di propaganda ambientalista piuttosto strumentale e ipocrita si continuano a importare dalla Cina in tutto il resto del mondo grandi quantità di cotone che è in buona parte lavorato da condannati ai lavori forzati, da “uiguri spediti nei “campi di rieducazione” per estirpare la religione musulmana dalle loro teste. Sicché esiste il rischio concreto che un consumatore di una grande marca occidentale stia – indirettamente – collaborando con la persecuzione di quel popolo a opera del regime di Pechino”. Anche grazie allo sfruttamento di questa particolare tipologia di risorse umane la Cina ha potuto accumulare negli ultimi anni così tante ricchezze da superare gli investimenti in ricerca degli Stati Uniti, e attualmente “Pechino è vicina a conquistare anche la leadership mondiale nell’intelligenza artificiale, un insieme di tecnologie con immense potenzialità sia per lo sviluppo economico sia per gli usi militari”.
Non si tratta di certo di una prospettiva rassicurante, e se Thomas Robert Malthus aveva già previsto, nel XIX secolo, “un’umanità condannata dalla sovrappopolazione e dalle carestie”, una simile catastrofe, già ampiamente in corso da vari lustri, da qualche anno non è di sicuro la più temuta, ammesso che lo sia mai stata. Secondo Rampini, infatti, la Cina oggi fa ancora più paura: per ragioni ambientali, geopolitiche e militari. Ciononostante, non si possono affrontare razionalmente tali fondati timori se non si considerano le difficoltà obiettive che possono esserci nel governare un Paese di 1,4 miliardi di persone: la Cina ha infatti già abbastanza da fare per salvare i suoi connazionali per potersi occupare con qualche effettivo senso della responsabilità del resto del mondo.
Pur essendo vero che l’economia cinese ha un impatto sull’ambiente globale superiore alla media e pur continuando la Cina a costruire nuove centrali a carbone, non si possono tuttavia ignorare le obiettive esigenze energetiche di un Paese così popoloso, che negli ultimi trent’anni ha visto aumentare tanto rapidamente il potere d’acquisto dei suoi cittadini e le sue capacità produttive. Un protezionismo ben temperato verso suoi prodotti potrebbe forse costituire la strategia migliore per arginare gli effetti negativi della sua economia su quella di tutto l’occidente e sugli equilibri geopolitici internazionali, ma anche per poter adottare una politica simile sarebbe necessaria una unità d’intenti e di analisi che oggi è ben lontana dall’essere all’orizzonte. Anche se Biden pare aver sottratto a Donald Trump la bandiera del protezionismo, la crescente indifferenza per i valori della liberaldemocrazia che si sta diffondendo in tutto l’occidente rende problematica l’adozione di qualsiasi strategia che non sia improntata al conseguimento di un vantaggio immediato e tangibile, con tutta la scarsa lungimiranza che una simile prospettiva comporta e tutte le insidie che ne conseguono.
A tutto questo bisogna poi aggiungere l’alleanza, strategica di fatto, con la Russia di Vladimir Putin, la quale, mentre impegna tutto l’occidente sul fronte europeo trova nella Cina un alleato prezioso nel pacifico, dove la difesa di Taiwan costringe gli Stati Uniti a impegnarsi in una doppia tutela di principi e di trattati internazionali che non possono essere lasciati a disposizione di Stati illiberali e autocratici con la disinvoltura con cui il polpo lascia i suoi tentacoli ai predatori di turno, pena il loro rafforzamento geopolitico e una guerra che, in un futuro non remoto, potrebbe rivelarsi, per un’alleanza di potenze declinanti, ancor più dolorosa e ardua da sostenere.